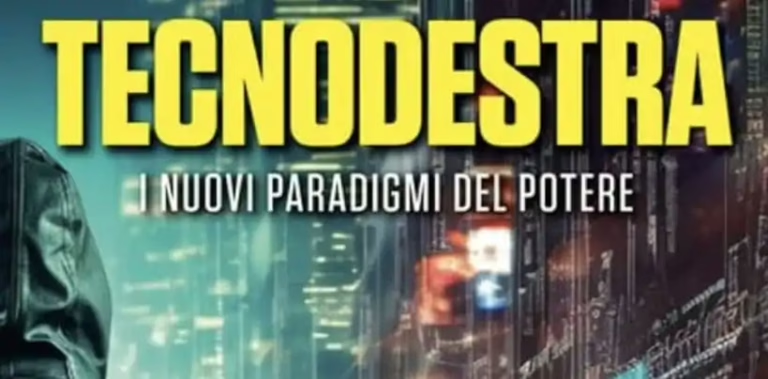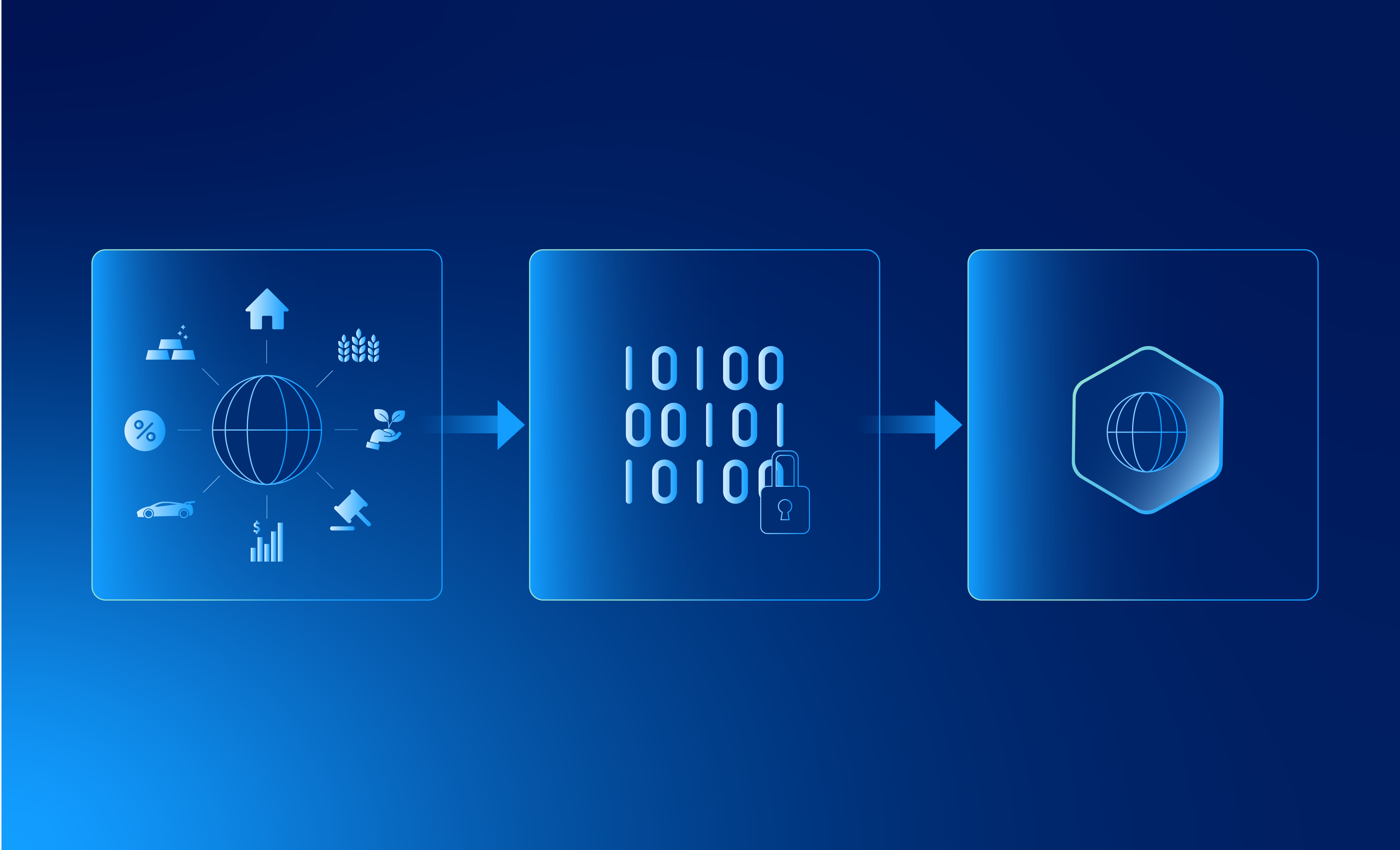Tecnodestra. I nuovi paradigmi del potere, di Andrea Venanzoni
Il primo, autentico studio in Italia sulla tecnodestra e i suoi protagonisti. Un’opera straordinaria di oltre 350 pagine con un solido corpus di note per comprendere fino in fondo la visione del mondo dei nuovi vincitori americani. La tecnodestra è qui, tra le aule delle Università, punteggia le pagine dei giornali e le parole degli editoriali, emerge nel lessico politico e nel dibattito pubblico.
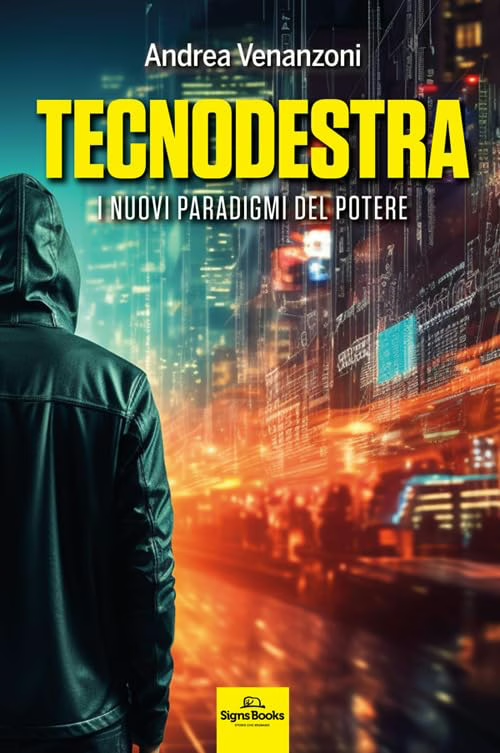
Ma cos’è, in concreto? Nonostante i toni terrorizzanti che accompagnano ogni gesto di Elon Musk o le parole di Peter Thiel, non è altro che la manifestazione di nuovi paradigmi di politica e di potere, nel cuore di una società che, sotto il maglio della digitalizzazione, va radicalmente mutando. E questo libro, ripercorrendo la storia della globalizzazione e la nascita delle grandi piattaforme digitali, del gaming e delle nuove dimensioni del pensiero filosofico-politico tipiche del digitale, si interroga su caratteristiche, differenze, contraddizioni e opportunità della tecnodestra. Su gentile concessione dell’editore, riportiamo di seguito un estratto dell’introduzione del libro:
«Le parole sono azioni, insegnava Ludwig Wittgenstein. Riescono, con il loro solo esserci, a determinare l’emersione di una data realtà, a evocare fatti e accadimenti, snudando un loro peso specifico capace di incidere sulla nostra vita, sul pensiero, sulle forme istituzionali.
A furia di utilizzare un dato termine, anche se per motivazioni sovente strumentali o di polemica politica, è possibile che quel dato fenomeno che col termine si definiva e perimetrava venga davvero a esistere. E ciò è ancora più vero in questo particolare tornante della storia umana, contraddistinto dalla presenza massiccia di poteri e strumenti digitali.
L’effetto di moltiplicazione e di irradiazione che le piattaforme digitali hanno importato nei confronti di idee, concetti, posizioni politiche e parole, appunto, ha trasformato, plasmato, geneticamente modificato il dibattito pubblico, spesso rendendo obsolete le vecchie categorie politologiche e giuridiche.
Il dibattito sulla libertà di espressione e di come questa, nel tritacarne di una comunicazione digitalizzata, disintermediata o forse più correttamente a dirsi neo-intermediata, è una palese e paradigmatica esemplificazione.
Per anni, abbiamo sentito difendere la libertà, forse anche quella più estrema, quando la stessa riguardava una certa sfumatura cromatica dello spettro politico, indulgendo in un doppio standard che però ora, per ironico paradosso, finisce per ritorcersi contro chi lo ha formulato e usato.
La retorica sulle piattaforme come “giardini privati”, liberissimi di fare e decidere e disfare come meglio credono, quando in gioco c’è la libertà di parola altrui, è logoramente nota.
Ora, ora che le piattaforme, sull’onda montante dell’attivismo di Elon Musk, hanno iniziato a mostrare un volto nuovo, comportamenti diversi, simpatie non più ostentatamente progressiste o addirittura woke, la grande massa dei commentatori scopre, urlando, il pericolo per la democrazia rappresentato dalle piattaforme stesse.
Poco importa che su quanto esse stessero incidendo nel profondo della nostra vita, delle nostre decisioni, delle nostre istituzioni rappresentative e della politica,la discussione in sede accademica fosse accesa da tempo.
Essendo l’università considerata poco meno che un cimitero di elefanti soliti parlare strano e scrivere pure peggio, il tutto interessava poco.
Eppure dal 2016, con la ascesa di Trump e la Brexit, con cioè il trionfo di una parte politica avversata da questo stesso mondo culturale e politico, la retorica è iniziata a cambiare e, a seguire, la legislazione modificata.
La libertà di parola, arrivati a questo punto, poteva divenire un’arma di distruzione di massa, un nemico della democrazia, gli algoritmi, combinati con la prima, improvvisamente da marchingegni quasi esoterici, di cui e su cui pochi sapevano davvero, si trasformavano in scettri del caos.
Del pari, a mutare è stata la natura stessa del dibattito e del livello delle polemiche; per la prima volta ci si è resi conto, con la destra “populista” al potere, che le fake news, la disinformazione e la post-verità sono fenomeni patologici capaci di aggredire gli elementi costitutivi e formanti del circuito elettorale, il libero convincimento degli elettori, di operare sulla sovranità.
Un’epifania strumentale, ovviamente, e partigiana.
Perché se un fenomeno è davvero patologico lo è di suo, non in quanto maneggiato dalla parte politica di volta in volta sgradita.
Naturalmente gli stessi titani del tech, e la vicenda della acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk come vedremo è assolutamente esemplificativa, si sono resi conto, spesso sulla loro pelle, che la libertà di parola nel mondo reale non ha la medesima intensità e il medesimo peso che le parole amplificate dalle reti digitali possono esercitare nel mare magnum di silicio, per il prima citato effetto di amplificazione.
Un discorso radicale, persino insultante, espresso per strada ha un determinato peso, una limitata audience, spesso confinata nell’orizzonte di una conversazione.
Un concetto parimenti radicale e anche qui insultante formulato in un articolo di giornale o durante una trasmissione televisiva avrà senza dubbio un peso specifico più elevato e un perimetro molto più vasto.
Ma né la strada, né la piazza o il giornale, la TV o la radio esercitano la forza dirompente di una rete digitale; la accelerazione del digitale, la moltiplicazione della potenza espansiva delle parole date in pasto al digitale, la viralità che abbatte barriere fisiche e temporali, linguaggi e limitazioni di ogni ordine e grado, assumono vesti e coloriture del tutto disruptive, anche in termini giuridici e politici.
Proprio per questo la partita che si gioca sulla moderazione dei messaggi e dei post e sul labile confine che separa la eliminazione di contenuti dalla censura vera e propria, e vedremo e dimostreremo che quando le piattaforme digitali sono costrette ad agire su impulso normativo statale esse censurano nel senso tecnico e proprio del termine, è una partita del tutto politica.
Si accennava ad un altro aspetto legato al potere di evocazione e di creazione della parola: la prospettiva che persino quanto non esista materialmente, a furia di essere definito e costantemente ripetuto, come in un mantra, venga a esistenza.
Nel campo della politica, infatti, dove lo spazio simbolico è sempre in costante movimento e dove ogni segno, ogni forma, ogni categoria, ogni etichetta, acquisiscono una valenza sostanziale, questa prospettiva assume ancora maggior valore.
Ed è così che il dibattito pubblico è stato occupato da un’apparentemente nuova definizione, dall’aroma politologico ma che, scavando bene, si scorge essere in prevalenza figlia della polemica politica: la tecnodestra.
Quotidiani progressisti, politologi, editorialisti, intellettuali, tutti preoccupati per le sorti della democrazia davanti al rullo compressore delle destre internazionali, nel cuore montante della agonia dei sistemi istituzionali governati da coalizioni di sinistra, e terrorizzati, letteralmente, da un fattore in apparenza nuovo che da ormai quasi dieci anni occupa la linea d’orizzonte della politica: il ruolo dei titani del tech.