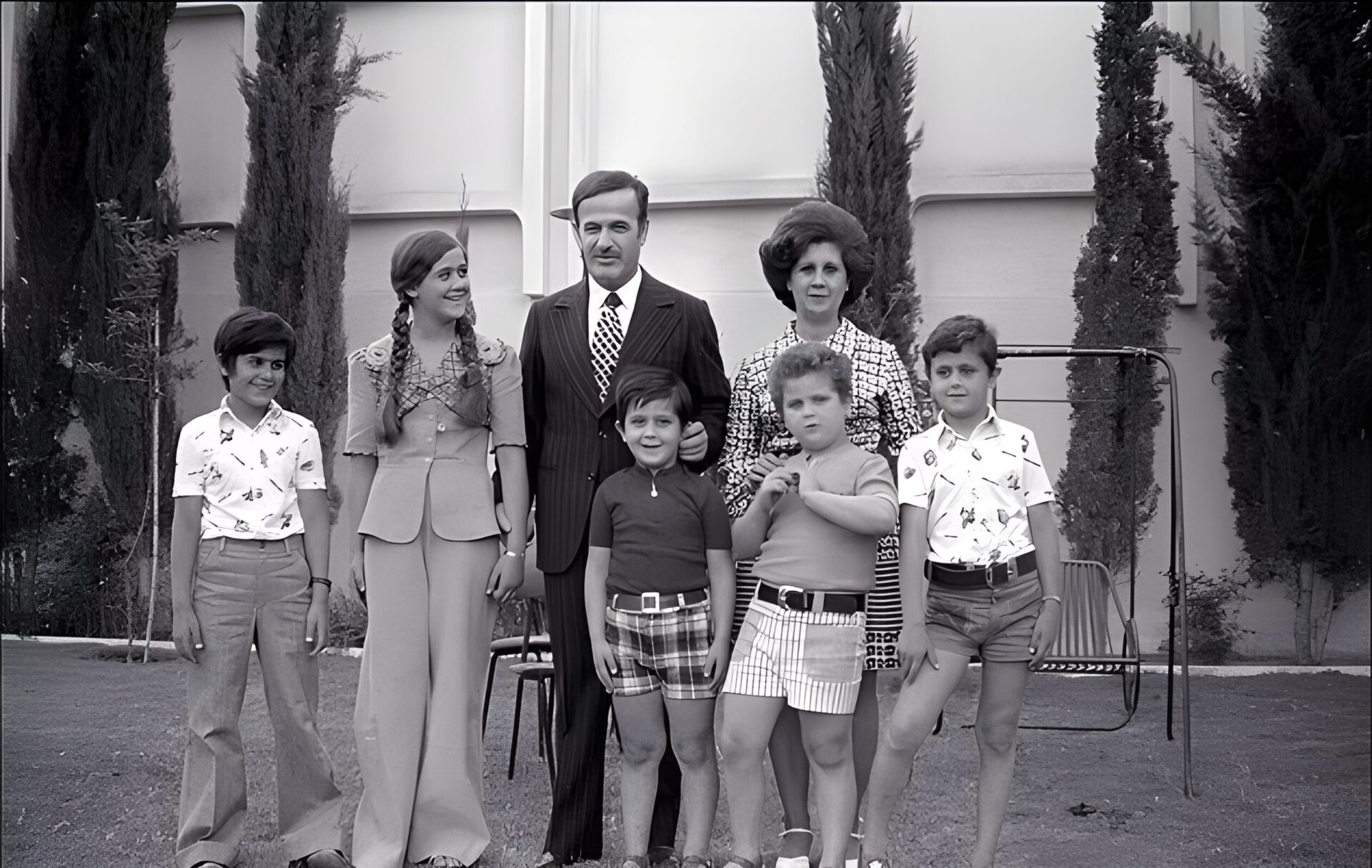Giù le carte, mr. President
Si dice che in campagna elettorale si può promettere la Luna e sparare talmente in alto da sfidare buon senso, logica e oggettività. È il consenso, bellezza, tutto è lecito. Se poi si vince ci sono anni per sperare che quelle promesse vengano dimenticate e per apprendere le mille tecniche collaudate di arrampicamento sugli specchi. Una disciplina che prima o poi troverà spazio e dignità tra i giochi olimpici.
Non è il caso di Donald Trump. In meno di tre mesi dall’insediamento presidenziale non solo sta cambiando le regole del gioco, ma il gioco stesso. Quella Luna promessa la sta scaraventando a terra a tempo di record.
Lo sta facendo negli Stati Uniti a colpi di decreti, tagli, nomine e continui colpi inferti al sistema. Ma lo sta facendo anche fuori dagli Stati Uniti, prendendo a calci tutto ciò che si frappone tra il suo modo di vedere (e volere) il mondo, e il mondo stesso. Non è più tempo di pensare globale.
È un negoziatore, pronto a bluffare, testare, rilanciare, passare perfino la mano (come già successo) o un uomo solo al comando che costi quel che costi arriva dritto alla meta? Questo è ancora tutto da vedere ma sta di fatto che i pochi giorni successivi alla pittoresca presentazione dei dazi in lavagna, hanno portato le borse del mondo intero sulle montagne russe (e stavolta Putin non c’entra).
Miliardi e miliardi bruciati in poche ore, interi comparti produttivi, a tutte le latitudini, paralizzati da timori, paure e prospettive nefaste. Lui ha deciso di bastonare ed emergere, non è dato sapere seguendo quale rudimento di politica economica. Vuole portare gli Stati Uniti ad un livello di competizione economica così aggressiva da non ritrovarne memoria in decenni, più probabilmente secoli. Roba che neanche Reagan o la Tatcher…
Gli esperti di tutto il mondo parlano di nuovo mercantilismo, di protezionismo, di guerra commerciale, dichiarata tanto ai nemici quanto agli amici, secondo calcoli e giustificazioni azzardate, strampalate, insostenibili. In fondo il messaggio è chiaro: non si punta all’efficienza ma al predominio, si ricostruisce la nazione ripartendo dalla dogana; “si torna a casa”. Più che una voce di bilancio è un sentimento.
America first!
Sì, ma anche i conti politici non sembrano tornare. I repubblicani guardano alle elezioni di medio termine con grande preoccupazione perché temono che i contro-dazi che il resto del mondo applicherà a Washington colpiranno gli Stati “agricoli” d’America che sono fucine di consenso elettorale, perlopiù repubblicano. Temono stagnazione, recessione, inflazione che, alle orecchie dei patrioti a stelle e strisce, suonano come parolacce.
Significativa la reazione di alcuni eletti del Gop: tentano di presentare un disegno di legge per limitare l’esuberanza del Presidente, imponendogli di dare un preavviso di 48 ore prima di ogni “sparata”. “Giusto il tempo per vendere o comprare azioni” avranno pensato i nipotini di Lincoln.
E i democratici? Ci provano Sanders e Cortez a scaldare le piazze e chiamare alla protesta nazionale, ma i deputati lavorano per far cadere lo stato di emergenza decretato da The Donald; un assegno in bianco che gli concede agilmente di suonare la musica che vuole e annunciare dazi su dazi. Insomma, quella Luna promessa e scaraventata a terra non ha più il sapore del miele.
E il mondo, che fa? Risposte, grida e silenzi, in ordine sparso. La Cina, vero obiettivo dichiarato oltre la cortina europea, risponde colpo su colpo. Torna alla mente la celebre scena di Fantozzi che, alla cena di gala della contessa Serbelloni, di fronte al tordo intero, gioca a rilanciare con il ragionier Filini sul nome dell’ambasciatore tedesco: “Otto… nove, dieci…trenta e lode, tiè”
Se non ci fosse da piangere ci sarebbe da ridere. La Cina vede le carte, rilancia, gioca.
Israele si allinea. I pinguini dell’isola sanzionata da Trump sono ancora in conclave. E l’Europa?
L’Europa al suo interno ha Stati che verranno duramente colpiti, a guardare la bilancia commerciale tra import ed export, Stati poco più che sfiorati e Stati a cui cambierà ben poco nella linea diretta della competizione con Washington. Ma si sa, il mercato esterno condiziona quello interno e sembra che, a fatica, l’Europa scelga di fare l’unica cosa sensata che può: non andare in ordine sparso con negoziazioni bilaterali (il sogno di Trump del sempreverde “dividi et impera”) ma parlare con un’unica lingua e più dialetti.
L’italia, tra le più preoccupate e colpite visto il calibro delle sue esportazioni, vuole andarci cauta, trovare appigli, accordi, fare compromessi; c’è troppo in ballo e fino in fondo non si è capito fin dove vuole spingersi l’ “amico” Donald. Altri paesi lucidano il cosiddetto bazooka, che altro non è che una serie di manovre di difesa e contrattacco che Bruxelles tiene pronte nel cassetto.
C’è però una questione di fondo che è perfino più importante del parmigiano, del vino, delle mozzarelle, del whisky, dell’acciaio e dell’alluminio. Mi riferisco alla fiducia.
Quale dazio e quale contro-dazio applichiamo alla fiducia? Il mondo degli affari si regge su questa “valuta universale”: la certezza che le regole sono regole e non si cambiano all’improvviso con un post, una diretta social o un pressure test. Perché se lo si fa, si percorre un terreno inesplorato su cui nessuno sa cosa potrebbe trovare, neanche l’unto del Signore, l’uomo dal ciuffo biondo nascosto dal cappello rosso su cui vengono imposte le mani e recitate preghiere per il futuro radioso che attende l’America.
Bene Presidente Trump, ora giù le carte.